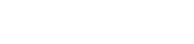La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da due donne contro il decreto del Tribunale di Treviso, che aveva negato il riconoscimento della figlia a due mamme.
Entrambe le donne sono cittadine italiane conviventi: una è madre biologica della bimba, che ha anche partorito, mente l’altra dichiara di essere ‘genitrice intenzionale’ per aver prestato il proprio consenso alla fecondazione assistita a cui si è sottoposta la compagna.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7668/2020, ritiene corretta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui richiama il divieto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla procreazione medicalmente assistita a cui possono fare ricorso solo le coppie maggiorenni di sesso diverso, anche se non coniugate (art. 5, L. 40/2004).
Questo divieto ha effettiva ripercussione sugli atti di nascita che devono essere formati o che si sono già formati in Italia, essendo possibile che solo una madre possa essere indicata nell’atto stesso e cioè la madre che ha un rapporto biologico/genetico con il figlio.
La Cassazione ripercorre ampi passaggi della sentenza n. 221/2019 emessa dalla Corte Costituzionale in materia.
Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale:
‘La possibilità – dischiusa dai progressi scientifici e tecnologici – di una scissione tra atto sessuale e procreazione, mediata dall’intervento del medico, pone, in effetti, un interrogativo di fondo: se sia configurabile – e in quali limiti – un “diritto a procreare” (o “alla genitorialità”, che dir si voglia), comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale. Più in particolare, si tratta di stabilire se il desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato.
Le soluzioni adottate, in proposito, dalla legge n. 40 del 2004 sono, come è noto, di segno restrittivo. Esse riflettono – quanto ai profili che qui vengono in rilievo – due idee di base.
La prima attiene alla funzione delle tecniche considerate. La legge configura, infatti, in apicibus, queste ultime come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati.
L’art. 1 della legge n. 40 del 2004 stabilisce, in particolare, che il ricorso alla PMA «è consentito» – alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa legge, «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» – «[a]l fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (comma 1) e sempre che «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (comma 2).
Il concetto è ribadito ed esplicitato nel successivo art. 4, comma 1, in forza del quale l’accesso alle tecniche di PMA «è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».
La seconda direttrice attiene alla struttura del nucleo familiare scaturente dalle tecniche in questione. La legge prevede, infatti, una serie di limitazioni di ordine soggettivo all’accesso alla PMA, alla cui radice si colloca il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre: limitazioni che vanno a sommarsi a quella, di ordine oggettivo, insita nel disposto dell’art. 4, comma 3, che – nell’ottica di assicurare il mantenimento di un legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori – pone il divieto (in origine, assoluto) di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (ossia con impiego di almeno un gamete di un donatore “esterno”).
L’art. 5 della legge n. 40 del 2004 stabilisce, in specie, che possano accedere alla PMA esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».’
‘L’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali, conseguente al loro accoglimento, esigerebbe, infatti, la diretta sconfessione, sul piano della tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore del 2004, con potenziali effetti di ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse dalle pratiche riproduttive (oltre che con interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili – in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come già accennato, che venga meno, almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata).‘
‘l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.’
La Corte di Cassazione non condivide neppure il ragionamento svolto dalle due ricorrenti che assimilano la loro condizione a quella dell’adozione di minori da parte delle coppie omosessuali.
Infatti, secondo la Corte di legittimità, l’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando e non ha quale scopo dare un figlio alla coppia, ma garantire una famiglia ad un minore che ne è privo.
Al contrario, la procreazione assistita serve per dare un figlio ad una coppia che ancora non lo ha e, quindi, non tutela l’interesse del minore, come nel caso dell’adozione, bensì la realizzazione di un’aspirazione genitoriale.
Poiché il bambino deve ancora nascere, il Legislatore vuole garantirgli le miglior ‘condizioni di partenza’, tra le quali non viene riconosciuta la presenza di due mamme, ma di una sola: quella con il legame biologico-genetico.