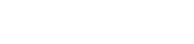Il caso affrontato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 27109/2021 riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata ad una azienda ospedaliera dai parenti di una paziente, deceduta all’esito di un intervento di angioplastica coronarica.
Secondo i parenti, la Corte d’appello non aveva considerato un fatto decisivo del giudizio: se i sanitari della struttura avessero rappresentato alla paziente i rischi connessi all’intervento di angioplastica, nonché la possibilità di eseguire detto intervento in un ospedale specializzato e opportunamente munito del reparto di cardiochirurgia , è plausibile ritenere che la donna avrebbe scelto di sottoporsi all’intervento in una struttura diversa. Ferma restando la possibilità di ricorrere a terapie alternative.
La Suprema Corte conviene con la prospettazione dei parenti e si sofferma sulla differenza che intercorre tra il consenso informato e l’intervento medico chirurgico.
Si distinguono due diritti precisi.
Il consenso informato attiene al ‘diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge‘.
Il trattamento medico terapeutico riguarda, invece, la tutela di un diverso diritto che è il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Concretamente, ne consegue che il trattamento sanitario eseguito senza il consenso informato è sicuramente illecito, sebbene l’intervento sia nell’interesse del paziente e tuteli la sua salute. Senza l’acquisizione del consenso, infatti, il trattamento sanitario non può essere eseguito.
Il consenso è validamente espresso se è stata fornita al paziente una corretta e chiara informazione.
L’informazione deve riguardare:
- la natura dell’intervento;
- i rischi ad esso legati;
- i possibili esiti negativi dell’intervento, l’eventualità di un aggravamento dello stato di salute, così come che le condizioni di salute, nonostante l’intervento, restino ‘inalterate’, prive del miglioramento che legittimamente ci si attende. Quindi, deve essere anche spiegato che l’intervento potrebbe risultare inutile e che il paziente si troverebbe a sopportare tutte le spese, le sofferenze e le ricadute psicologiche legate alla persistenza della malattia.
La struttura e il medico devono adottare un linguaggio comprensibile per il livello culturale del paziente e per il suo soggettivo grado di conoscenze, affinchè l’informazione sia effettivamente compresa.
Solo il paziente, infatti, è titolare del diritto al consenso informato, solo lui deve valutare i rischi della sua scelta e per poterlo fare deve avere tutti gli elementi necessari.
Il consenso informato garantisce la libertà di autodeterminazione terapeutica.
Il diritto al consenso informato è legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: se manca, possono aversi conseguenze anche nella violazione del diritto alla salute, nel caso in cui l’atto terapeutico, pur eseguito con ogni diligenza, abbia provocato effetti pregiudizievoli che non erano conosciuti dal paziente. Il paziente può provare che, se avesse ricevuto tutte le informazioni del caso, non si sarebbe sottoposto all’intervento, seppur ben riuscito.
Nel caso concreto affrontato, i medici della struttura avevano omesso di raccogliere il consenso informato sul presupposto che fosse necessario intervenire con urgenza con un’operazione presumibilmente indispensabile al paziente per sopravvivere. Tuttavia, era stato dimostrato nel corso del giudizio che la stessa struttura aveva programmato l’intervento a distanza di due giorni, fatto in sè che dimostrava l’assenza di un’urgenza tale da impedire di fornire tutte le informazioni dovute e raccogliere il consenso all’intervento.
La struttura sarà, quindi, tenuta a risarcire i parenti.