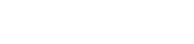La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9691 del 24.3.2022, ha affermato la non utilizzabilità nei procedimenti di diritto di famiglia del concetto di PAS, ribadendo con maggior vigore quanto già espresso in precedenti sentenze rimaste ignorate dai Tribunali di merito.
La sindrome da alienazione parentale (c.d. PAS) è stata al centro della vicenda che ha visto una madre, che da anni ostacolava il diritto di visita tra padre e figlio, venire allontanata dal proprio figlio, collocato presso una casa famiglia, per garantire al padre la possibilità di riprendere a vedere il bambino.
Le tre consulenze tecniche d’ufficio svolte avevano illustrato come il bambino avesse subito nel tempo pressioni psicologiche da parte della madre che screditava la figura paterna, così inducendo il figlio a stabilire una ‘patto di lealtà’ alla madre.
Secondo il Tribunale dei minori ‘emergeva dagli atti la grave condizione di pregiudizio del minore incastrato in un rapporto di lealtà con la madre che non gli permetteva di autodeterminarsi ed esprimere la sua volontà senza coercizioni, attesa la condotta della madre che volontariamente o involontariamente non gli consentiva l’accesso alla figura paterna’.
La madre, ricorrendo alla Suprema Corte, osserva che non può essere fatto riferimento alla PAS come base di un provvedimento giudiziario poiché sprovvista di fondamento scientifico.
La Cassazione, nel ripercorrere la vicenda, precisa che qualora vi siano comportamenti tenuti da un genitore di allontanamento morale e materiale del figlio dall’altro genitore, riconducibili alla sindrome da alienazione parentale, è preciso compito del Giudice verificare la veridicità dei comportamenti descritti, indipendentemente dal giudizio astratto sulla validità scientifica o meno della PAS.
Infatti, ‘tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 6919/16; n. 7041/13)’
Nel caso di specie era stato verificato che i rapporti tra figlio e padre fossero effettivamente sempre stati ostacolati dalla madre. Tale condotta è contraria al principio di bigenitorialità che esiste, innanzitutto, come best interest del minore e deve effettivamente concretizzarsi nella presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio.
La Corte EDU ha sancito che ai sensi dell’art. 8 della CEDU deve essere rispettata la vita privata famigliare, evitando di creare fratture nelle relazioni famigliari con particolari restrizioni al diritto di visita dei genitori e ha raccomandato alle autorità nazionali di adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra genitori e figli.
Il diritto alla bigenitorialità e all’attuazione di tale diritto, però, non possono portare a misure estreme quali, come nel caso di specie, la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre con conseguente allontanamento del figlio dalla madre. Tale misura, infatti, sebbene in presenza dell’accertato ostruzionismo della madre, è estrema e recide il rapporto tra madre e figlio in maniera ingiustificata.
In sintesi, non si può garantire il diritto a conservare un rapporto significativo con il padre allontanando il minore dalla madre.
La cassazione richiama l’art. 337 ter c.c., l’art. 8 CEDU e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con la legge n. 176/91.
L’interesse del minore è un diritto sostanziale e deve essere valutato come predominante in presenza di più interessi in gioco; in caso di più interpretazioni possibili di una norma, va privilegiata quella che corrisponde al best interest del minore, a discapito di altri diritti con esso concorrenti.
Si legge nella pronuncia: ‘le valutazioni strettamente psicologiche espresse dai c.t.u., cui la Corte d’appello, come detto, rinvia laconicamente e genericamente, senza svolgere alcun vaglio critico, presentano perplessità interpretative poiché, pur muovendo dai fatti indubbi inerenti all’ostruzionismo della ricorrente verso l’ex-compagno, fanno comunque riferimento al postulato patto di lealtà tra madre e figlio, o al condizionamento psicologico (espressione menzionata nel decreto impugnato), termini espressivi o suggestivi che lasciano aleggiare la teoria della sindrome da alienazione parentale di cui parla espressamente il c.t.u. quale forma specifica di abuso psicologico che la accomuna, ex art. 333 c.c., alle altre forme di violenza.(…) il richiamo alla sindrome da alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.’
Altro tema fondamentale toccato dalla pronuncia è l’omesso ascolto del minore che è adempimento previsto a pena di nullità, completamente ignorato dal giudice. Il minore, pur non essendo parte formale del giudizio, è parte sostanziale perché portatore di un proprio interesse diverso da quello dei genitori. Il suo ascolto era rilevante, oltre che obbligatorio, e avrebbe probabilmente permesso una valutazione dei desideri e dell’autodeterminazione del minore più genuina e diretta, chiarendo i reali rapporti intercorrenti con il padre e con la madre.